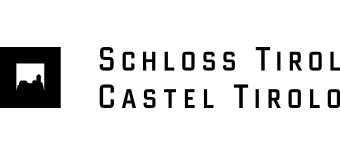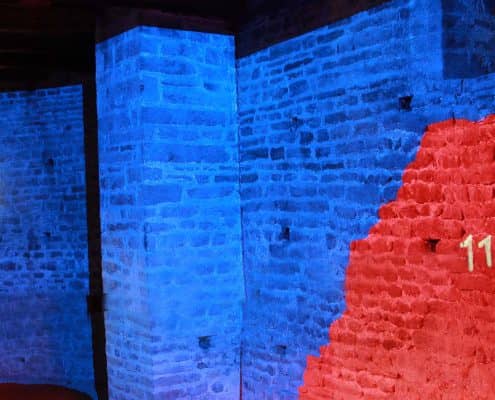Museo storico-culturale
della Provincia di Bolzano
via Castello, 24
I-39019 Tirolo (BZ)
Tel. +39-0473 220 221
info@casteltirolo.it
guide@casteltirolo.it
st.mct@pec.prov.bz.it
via Castello, 24
I-39019 Tirolo (BZ)
Tel. +39-0473 220 221
info@casteltirolo.it
guide@casteltirolo.it
st.mct@pec.prov.bz.it
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento. Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Usa il pulsante “Rifiuta” o chiudi questa informativa per continuare senza accettare.
AccettaRifiutaImpostazioni
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Puoi scegliere di impedire a questo sito web di aggregare e analizzare le azioni che intraprendi qui. Ciò proteggerà la tua privacy, ma impedirà al proprietario di imparare dalle tue azioni e di creare un'esperienza migliore per te e per gli altri utenti.
Facebook – Twitter – Google+ – Youtube – Vimeo
Modalità per la gestione dei cookie:
Facebook - Twitter - Google+ - Youtube - Vimeo
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti"). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per esempio Facebook, Twitter, Google+, Youtube e Vimeo. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. Se non desiderate che Facebook – Twitter – Google+ – Youtube – Vimeo raccolga queste informazioni su di voi, dove disconnettervi dal vostro account prima di visitarci.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.
Qui trovi la nostra privacy policy nel dettaglio.